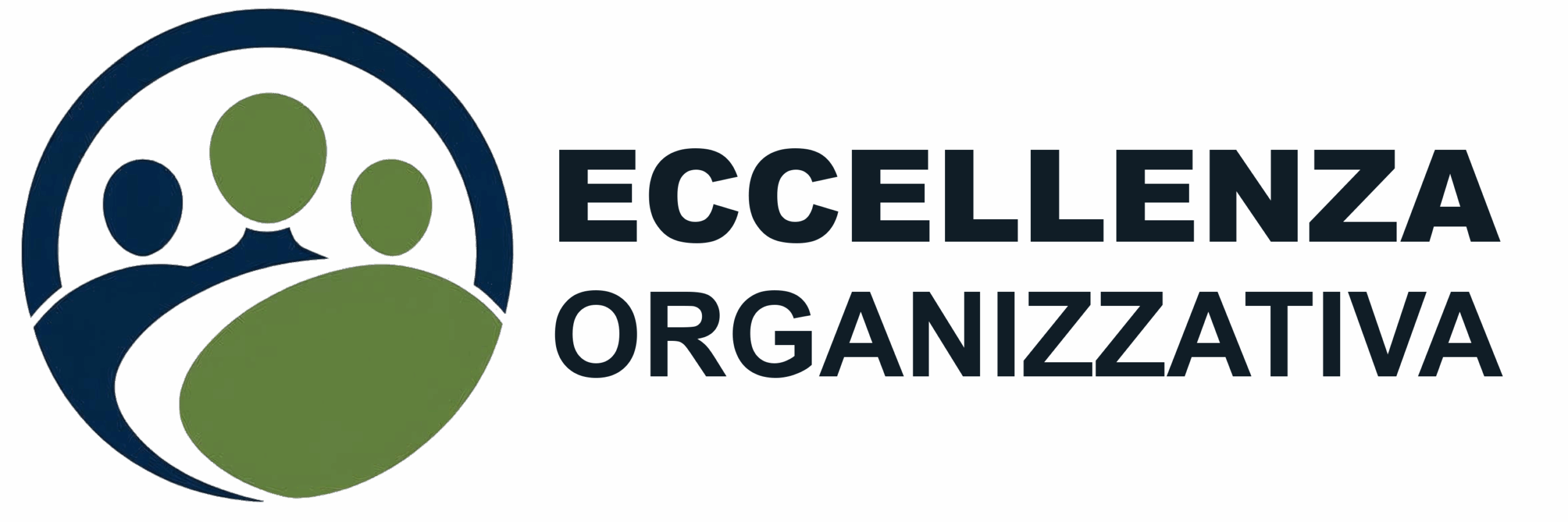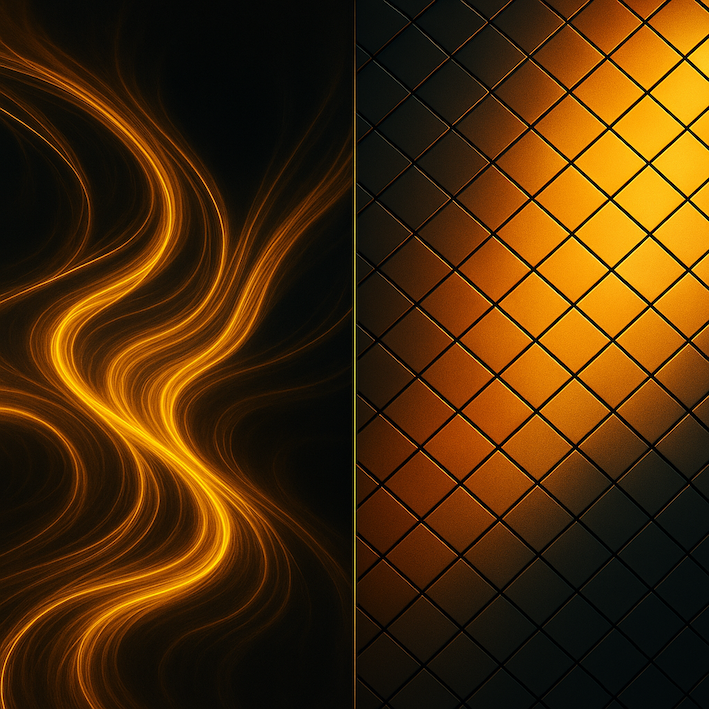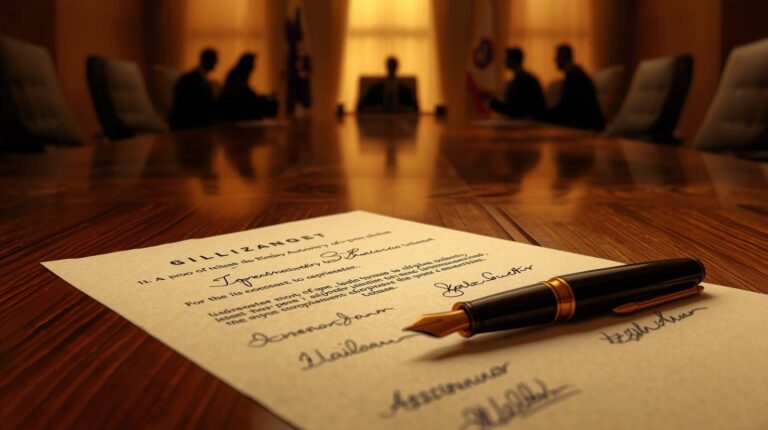Operational Excellence e oltre: l’Eccellenza Organizzativa
La confusione terminologica
Nel linguaggio quotidiano delle aziende sentiamo parlare di Operational Excellence, Continuous Improvement, Quality Excellence, Business Excellence. Spesso questi termini vengono usati come sinonimi oppure come etichette intercambiabili per indicare “fare meglio”. Il risultato? Progetti importanti che nascono con buone intenzioni ma con obiettivi ambigui, aspettative diverse tra funzioni e, alla fine, risultati che non si consolidano.
Questa confusione non è un problema di semantica: ha un costo organizzativo reale. Quando non distinguiamo bene i concetti, finiamo per misurare ciò che è comodo anziché ciò che conta, per ottimizzare localmente invece di migliorare sistemicamente, per lanciare iniziative “a isole” che faticano a scalare. È così che programmi di miglioramento anche ben progettati si affievoliscono dopo i primi mesi, cambiano nome a ogni riorganizzazione o vengono ricordati come “il progetto di moda di quell’anno”.
C’è un secondo effetto collaterale: la disallineata aspettativa degli stakeholder. Per alcuni Operational Excellence significa ridurre i costi in fabbrica, per altri trasformare i processi end-to-end, per altri ancora introdurre nuovi KPI o digitalizzare. Se ognuno proietta sul termine la propria idea, la governance si indebolisce e la priorità strategica si disperde. In questo spazio grigio prosperano attività che “riempiono” i calendari senza incidere davvero sulla competitività.
Per superare questo stallo serve una cornice chiara, condivisa e misurabile. Nell’articolo proponiamo di recuperare il significato pieno di Eccellenza Organizzativa come prospettiva guida: non uno slogan, non l’ennesima buzzword, ma la regia che allinea scelte strategiche, leadership, processi, persone e risultati lungo un’unica direzione. Solo dentro una cornice organizzativa esplicita le iniziative operative smettono di essere episodi e diventano capacità.
Nei punti successivi chiariremo i termini più usati (senza sovrapporli), spiegheremo perché i progetti “operativi” falliscono in assenza di una visione organizzativa e mostreremo come riportare Operational e Business Excellence dentro una struttura che li renda continui, scalabili e utili.
Glossario minimo: Operational Excellence e altri termini chiave
Quando in azienda si parla di “eccellenza”, non tutti intendono la stessa cosa. C’è chi usa Operational Excellence, chi preferisce Continuous Improvement, chi parla di Business Excellence o di Quality Excellence. Spesso questi termini vengono usati come se fossero equivalenti, eppure nascondono sfumature importanti. Capirle è fondamentale per non confondere gli obiettivi e per dare coerenza agli sforzi di trasformazione.
Eccellenza Organizzativa (EO) è la cornice più ampia. Significa saper mettere in relazione strategia, leadership, processi, persone e risultati per creare valore sostenibile nel tempo e per tutti gli stakeholder: clienti, dipendenti, azionisti, comunità. È un concetto sistemico: non riguarda un reparto o un singolo indicatore, ma la capacità complessiva dell’organizzazione di funzionare in modo coerente e orientato al futuro.
Business Excellence (BE) viene spesso usato come sinonimo di EO, soprattutto nei contesti legati a EFQM o Baldrige. La differenza è sottile ma rilevante: mentre BE mette l’accento sulle performance del “business” e sulla competitività, EO abbraccia anche la dimensione culturale, la governance e gli stakeholder non economici. In un’impresa profit le due definizioni possono coincidere; in una pubblica amministrazione, in un ospedale o in un’organizzazione non profit, la nozione di Eccellenza Organizzativa è decisamente più inclusiva.
Operational Excellence (OpEx) riguarda invece l’efficienza operativa: ridurre sprechi e variabilità, aumentare la produttività, migliorare la qualità e i tempi di risposta. È una disciplina molto concreta, legata ai processi, e punta a “fare bene le cose” ogni giorno.
Continuous Improvement (CI), o Kaizen, è la filosofia dei piccoli passi: tanti miglioramenti incrementali proposti e realizzati dalle persone in prima linea. È più un comportamento organizzativo che un progetto, e funziona solo se radicato nella cultura aziendale.
Infine, Quality Excellence è l’evoluzione della funzione qualità: garantire conformità, ridurre difetti, migliorare prodotti e servizi. È cruciale, ma se rimane confinata alla sola funzione rischia di non incidere sulla direzione complessiva dell’organizzazione.
📌 In sintesi:
- Eccellenza Organizzativa è la cornice.
- Business Excellence ne è una declinazione più centrata sui risultati economici.
- Operational Excellence, Continuous Improvement e Quality Excellence sono discipline e strumenti specifici che, se isolati, non bastano.
Perché i progetti di Operational Excellence falliscono senza visione organizzativa
I programmi di miglioramento hanno spesso un destino simile. Nascono con entusiasmo, generano qualche risultato tangibile nei primi mesi, ma finiscono per esaurirsi. La spiegazione non sta nella validità degli strumenti: Lean, Six Sigma o Kaizen hanno dimostrato la loro efficacia in migliaia di contesti. Il problema è che, se rimangono confinati a iniziative operative, manca loro la continuità e la coerenza necessarie per durare.
Quando un progetto non è legato in modo chiaro agli obiettivi strategici dell’organizzazione, viene percepito come un’attività accessoria. In un primo momento può generare risparmi o miglioramenti locali, ma alla prima riorganizzazione o cambio di priorità rischia di essere accantonato. Lo stesso accade quando la sponsorship della leadership è debole: senza un impegno visibile e costante del top management, qualsiasi iniziativa di miglioramento viene travolta dalla routine quotidiana.
C’è poi un altro nodo critico: l’approccio troppo tecnico. In molte aziende si introducono strumenti e metodologie con competenza, ma senza un lavoro parallelo sulla cultura e sulle persone. Il risultato è che i miglioramenti restano confinati a pochi specialisti, senza diventare patrimonio diffuso. A questo si aggiunge la frammentazione: reparti diversi avviano ciascuno la propria “caccia al miglioramento”, senza un filo conduttore. Si ottengono tanti micro-risultati, ma non un impatto sistemico.
Infine, il tema delle misurazioni. Se i progetti operativi si limitano a tracciare indicatori interni — riduzione scarti, tempi di processo, risparmi di costo — ma non dimostrano valore per clienti, dipendenti o azionisti, la percezione di utilità resta bassa. Senza una narrazione chiara dell’impatto, le priorità si spostano altrove e l’energia si disperde.
Ecco perché così tanti progetti operativi finiscono per spegnersi: mancano di una regia organizzativa che li inserisca in un disegno più grande. Solo quando sono collegati alla strategia, supportati da una leadership visibile e accompagnati da una cultura di coinvolgimento, possono trasformarsi da iniziative temporanee in capacità permanenti.
La cornice dell’Eccellenza Organizzativa come regia
Se i progetti operativi tendono a spegnersi, è perché mancano di una regia. L’Eccellenza Organizzativa rappresenta proprio questa regia: la cornice che trasforma iniziative puntuali in un percorso coerente, capace di generare valore nel tempo.
La sua forza sta nell’allineare elementi che, presi singolarmente, non bastano: la strategia, la leadership, i processi, le persone, le partnership e i risultati. È un modello che non si limita a chiedere “cosa possiamo migliorare”, ma soprattutto “perché e in che direzione conviene migliorare”.
Quando un’iniziativa di Operational Excellence viene inserita in questa cornice, non è più un progetto isolato di riduzione sprechi: diventa parte di un disegno che collega l’efficienza operativa agli obiettivi strategici e, a cascata, agli impatti su clienti e stakeholder. Se si introduce un programma di Continuous Improvement, non è più una raccolta di idee sparse: diventa un meccanismo organizzato per coinvolgere le persone nel raggiungimento di priorità chiare. Persino la Quality Excellence smette di essere un presidio funzionale e diventa un elemento che attraversa tutti i processi, collegato a valore percepito e fiducia del mercato.
La regia dell’Eccellenza Organizzativa assicura tre condizioni decisive:
- che la leadership sia visibile e coerente, così le iniziative non perdono sponsorship;
- che ci sia coerenza tra le priorità strategiche e i progetti operativi, evitando dispersione;
- che la cultura organizzativa sostenga il cambiamento, trasformando strumenti e tecniche in comportamenti diffusi.
In altre parole, l’Eccellenza Organizzativa è ciò che permette alle aziende di passare dall’episodico al sistemico. È la differenza tra “fare un progetto Lean” e “diventare un’organizzazione che apprende e migliora costantemente”.
I modelli come riferimento e legittimazione
L’Eccellenza Organizzativa non nasce come concetto astratto: negli ultimi decenni è stata tradotta in modelli concreti, utilizzati da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo per misurarsi, migliorare e crescere. Tra i più noti e consolidati troviamo l’EFQM Model, il Baldrige Performance Excellence Framework e lo Shingo Model.
L’EFQM Model, nato in Europa, è probabilmente il punto di riferimento più diffuso nel nostro continente. La sua forza è l’approccio sistemico: non si limita a guardare processi o risultati, ma abbraccia leadership, strategia, persone, partnership, risorse e impatti sulla società. È costruito per aiutare le organizzazioni a porsi domande di fondo: chi siamo, dove vogliamo andare, come possiamo creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder.
Negli Stati Uniti il Baldrige Framework ha svolto un ruolo simile: offrire un modello di valutazione e miglioramento che va oltre la qualità operativa e si spinge fino alla governance, all’innovazione e alla capacità di adattamento. Per molte multinazionali, soprattutto americane, “fare eccellenza” significa ancora oggi confrontarsi con i criteri Baldrige.
Lo Shingo Model, infine, è nato dall’esperienza del lean management e delle operations, ma nel tempo ha ampliato il focus fino a includere la cultura organizzativa e i principi che sostengono l’eccellenza di lungo periodo. La sua particolarità è sottolineare che la vera trasformazione non è mai solo tecnica, ma parte dai comportamenti delle persone e dai valori che guidano l’organizzazione.
Pur con differenze di accento, questi modelli hanno un tratto comune: trasformano l’Eccellenza Organizzativa in pratica osservabile e misurabile. Forniscono criteri, domande, strumenti di autovalutazione che permettono a un’organizzazione di capire dove si trova e quali passi deve compiere. In altre parole, danno una legittimazione concreta a quello che altrimenti rischierebbe di restare un concetto astratto.
Ecco perché parlare di Eccellenza Organizzativa non è marketing: significa richiamarsi a standard riconosciuti a livello internazionale, adottati da aziende e istituzioni che vogliono andare oltre l’efficienza operativa e costruire capacità organizzative durature.
Marketing del termine in Italia: Operational Excellence vs Eccellenza Organizzativa
In Italia, chi cerca opportunità di carriera o consulenza nel campo dell’“eccellenza” si imbatte quasi sempre in titoli come Operational Excellence Manager, Continuous Improvement Leader o Quality Excellence Specialist. La dicitura Organizational Excellence è invece quasi assente dagli annunci di lavoro e dai portali di recruiting.
Questo non significa che il concetto non abbia valore, ma che il mercato italiano adotta un lessico più tecnico e operativo. Le aziende cercano figure che migliorino processi, efficienza e costi. Parlare di Eccellenza Organizzativa richiede quindi uno sforzo in più: spiegare che non si tratta solo di fare bene le cose, ma di costruire un sistema che decide quali cose vale la pena fare e come farle durare nel tempo.
A livello internazionale la situazione è diversa: nei paesi anglosassoni e soprattutto nell’area MENA (Middle East & North Africa) “Organizational Excellence” è una keyword consolidata, spesso associata esplicitamente al modello EFQM. Lì il mercato riconosce direttamente la figura dell’Organizational Excellence Manager o dello EFQM Assessor.
Per questo, usare il termine in Italia ha un duplice effetto:
- da un lato può sembrare meno immediato e rischia di essere percepito come accademico;
- dall’altro lato è differenziante: chi riesce a spiegare bene cosa significa EO si posiziona come consulente o leader capace di andare oltre le ottimizzazioni locali e proporre una visione più ampia.
📌 In pratica, il “marketing del termine” consiste nel colmare questo gap: non sostituire “Operational Excellence” con “Eccellenza Organizzativa”, ma mostrare come l’una sia parte dell’altra. Così il lettore italiano riconosce il termine familiare (Operational Excellence) e allo stesso tempo scopre che esiste un concetto più ampio che lo rende sostenibile.
Conclusione: Dare centralità all’Eccellenza Organizzativa
Nel linguaggio manageriale contemporaneo abbondano termini affascinanti: Operational Excellence, Continuous Improvement, Quality Excellence, persino Business Excellence. Ognuno ha la sua validità, ma tutti rischiano di restare parziali se non vengono ricondotti a una cornice più ampia. È qui che entra in gioco l’Eccellenza Organizzativa.
Pensare in termini di Eccellenza Organizzativa significa smettere di considerare i progetti operativi come iniziative a sé stanti e iniziare a vederli come tasselli di un disegno unitario. Significa passare dall’episodico al sistemico, dall’entusiasmo del “progetto di moda” alla capacità di apprendere, adattarsi e crescere in modo continuo.
I modelli internazionali — dall’EFQM al Baldrige fino allo Shingo — ci ricordano che questo non è un concetto astratto, ma un approccio pratico che può essere misurato, valutato e soprattutto reso concreto nei comportamenti quotidiani delle persone.
In Italia, il termine “Eccellenza Organizzativa” non è ancora familiare quanto “Operational Excellence”. Ma proprio per questo vale la pena usarlo: non come slogan, bensì come chiave per aprire nuove prospettive. Aiuta le imprese a capire che l’efficienza operativa è importante, ma non basta; che i miglioramenti locali hanno valore, ma solo se inseriti in una strategia coerente; che la qualità non è un reparto, ma un modo di gestire l’organizzazione nel suo insieme.
In un tempo in cui la complessità cresce e le sfide non si risolvono con ricette parziali, ridare centralità all’Eccellenza Organizzativa significa dare alle aziende una bussola, non solo una cassetta degli attrezzi. È questo il salto che distingue chi si limita a migliorare processi da chi sa costruire organizzazioni realmente capaci di prosperare.